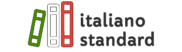Nelle ultime settimane i mass media italiani hanno parlato soprattutto della piega che stanno prendendo le relazioni transatlantiche in merito alla questione ucraina. Stampa, radio e TV, soprattutto il web, si sono riempiti delle sequenze di colloquio alla Casa Bianca di Washington, dove è andata in scena una rappresentazione inedita dei rapporti di forza tra una piccola e una grande potenza, fra l’Ucraina e gli Stati Uniti d’America.
Ne sono circolate diverse versioni parodistiche, un modo per sdrammatizzare i termini di una discussione aspra come mai nella storia recente delle relazioni internazionali. Alcune di queste versioni italiane fanno ricorso al dialetto che riporta alla dimensione locale, perciò più vicina al cuore della gente, una questione di rilievo mondiale, rendendola meno insopportabile di quanto sia in lingua standard.
L’ospite ucraino si è ritrovato a difendere le sue ragioni nella lingua del padrone di casa, la cui voce grossa non ha aiutato ad abbassare quel filtro emotivo più o meno spesso che si pone in mezzo a interlocutori di lingue diverse, specialmente quando la posta in gioco è molto alta. Per citare Trump, Zelensky non ha buone carte in mano; peraltro Trump imbroglia le carte.

Di fronte a una situazione confusa e difficoltà oggettive, l’uso della madrelingua è di qualche conforto, come conferma la debole voce del capo della Chiesa cattolica. Papa Francesco, dal suo ricovero in ospedale a Roma, ha scelto di rivolgersi in spagnolo ai molti fedeli che in ogni parte del mondo sono in ansia per la sua salute.
La salute del papa è stato l’altro tema che si è molto discusso in Italia nelle scorse settimane. Che si creda o no, il cattolicesimo è una componente fondamentale del modello storico-sociale italiano, in crisi come ogni altro elemento d’identità. Nel bene e nel male, il papa – questo papa – è un punto di riferimento della morale universale.
Nell’anniversario dell’ascesa al soglio pontificio di Jorge Mario Bergoglio, il 13 marzo 2013, mi fa piacere ricordare quanto di bello resta della Roma papale. Non solo la maestà della basilica di San Pietro, ma anche l’architettura civile di piazza del Campidoglio, altro grande progetto del genio rinascimentale cui è dedicata la più recente delle Pillole di italiano: Michelangelo.
La prossima settimana, invece, Mogadiscio 1994 ricorderà la tragica fine di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, reporter che raccontarono per il pubblico italiano una fase della guerra civile nella ex colonia. Per un ritorno in Somalia, si può ancora ascoltare la pillola d’un paio d’anni fa, Mogadiscio 1948, che ricorda un episodio della decolonizzazione. Allora come oggi, in tempo di guerra, la voce del giornalismo indipendente si alza nel deserto del conformismo mediatico.